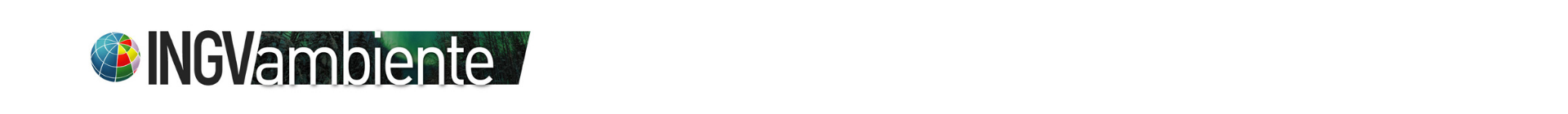Le microplastiche: non tutto il male vien per nuocere
Le famigerate microplastiche inquinano i nostri mari. Ma la caratteristica di essere vettori di trasporto di inquinanti, trova un’utile applicazione: possiamo usarle come traccianti per il monitoraggio dell’inquinamento dell’ambientale marino
di Marina Locritani e Silvia Merlino
Si parla spesso di inquinamento dei mari, ma raramente andiamo oltre ciò che possiamo vedere. Le immagini di tartarughe intrappolate nei rifiuti o di uccelli marini con lo stomaco pieno di plastica colpiscono la nostra sensibilità, ma rappresentano solo la parte più visibile del problema.
Se guardiamo più da vicino, scopriamo che il mare nasconde inquinanti invisibili, minuscoli ma pericolosi, capaci di viaggiare per migliaia di chilometri e di accumularsi negli organismi viventi.
Ma di che sostanze si tratta? Come si muovono nell’ambiente? E da dove arrivano?
Le microplastiche
Tra gli inquinanti invisibili, le microplastiche sono tra i più diffusi. Si tratta di minuscole particelle di plastica che finiscono direttamente nell’ambiente, spesso attraverso gesti quotidiani: il risciacquo di prodotti cosmetici, dentifrici o detergenti che contengono microbeads, oppure la dispersione di granuli plastici utilizzati come materia prima industriale (le cosiddette microplastiche di origine primaria, o resin pellets, grandi circa 4 millimetri).
Esistono poi le microplastiche di origine secondaria, che si formano quando frammenti di plastica più grandi si degradano nel tempo a causa della luce solare e dell’azione del mare.
Le microplastiche, però, non sono l’unico tipo di contaminante capace di accumularsi e diffondersi negli ecosistemi marini. A fianco di queste particelle solide esiste una categoria di inquinanti molto più insidiosa: le sostanze chimiche persistenti, difficili da degradare e presenti ovunque, dai fondali oceanici all’atmosfera.
Gli inquinanti organici persistenti (POPs)
Accanto alle microplastiche, nei mari e nei fiumi del nostro pianeta si trovano anche gli inquinanti organici persistenti, noti con la sigla POPs (Persistent Organic Pollutants).
Si tratta di sostanze chimiche molto stabili, resistenti alla degradazione biologica, che tendono quindi ad accumularsi negli ecosistemi e negli organismi viventi.
Questi composti sono solubili nei grassi ma non in acqua, e per questo si legano facilmente ai tessuti degli animali e del suolo. Alcuni possono restare nell’ambiente per decenni prima di degradarsi.
Tra i POPs più noti troviamo:
-
i policlorobifenili (PCB), prodotti per usi industriali e commerciali, in passato utilizzati come fluidi dielettrici in trasformatori e condensatori, ritardanti di fiamma, additivi per vernici e plastificanti;
-
gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che derivano dalla combustione incompleta del carbonio, rilasciati soprattutto da sorgenti antropiche, come le centrali termoelettriche a carbone o i processi industriali.
Queste sostanze, per la loro elevata affinità con i lipidi e con il materiale organico, tendono ad accumularsi lungo la catena alimentare. Tracce di POPs sono state trovate in pesci, animali selvatici, nel latte e persino nel sangue umano.
Come si monitora l’inquinamento marino
I POPs si diffondono su scala globale: viaggiano nell’aria, nelle acque e nei sedimenti, trasportati dalle correnti e dai venti.
Monitorarli è essenziale per capire come e dove si accumulano le sostanze tossiche, e per individuare eventuali rischi per la salute umana e per gli ecosistemi marini.
Ma come si fa, in pratica, a misurare la presenza di queste sostanze nei mari?
Tradizionalmente si utilizzano organismi filtratori come i mitili, ma negli ultimi anni la ricerca ha esplorato un metodo alternativo, sorprendentemente efficace: le microplastiche stesse come traccianti di inquinamento.
I mitili come sentinelle del mare
Uno dei metodi più utilizzati per monitorare gli inquinanti è l’analisi dei mitili (Mytilus galloprovincialis). Questi molluschi filtrano grandi quantità d’acqua e accumulano nei loro tessuti le sostanze presenti nell’ambiente, diventando veri e propri bioindicatori della qualità delle acque.
Tuttavia, analizzare i mitili non è semplice: la presenza di materiale lipidico nei loro tessuti può interferire con le fasi di estrazione degli inquinanti, rendendo i risultati meno precisi e i tempi di analisi più lunghi.
Le microplastiche come “spugne chimiche”
Anche alcuni tipi di pellets plastici (le microplastiche di origine primaria) galleggiano sulla superficie marina grazie alla loro bassa densità (0,88–0,96 g/cm³, inferiore a quella dell’acqua). La loro natura lipofilica, cioè la capacità di attrarre oli e grassi, li rende simili a spugne chimiche: assorbono o rilasciano inquinanti a seconda delle condizioni ambientali.
Questo comportamento ha due conseguenze:
-
da un lato, i pellets possono trasportare inquinanti da zone fortemente antropizzate a regioni remote, come le aree polari;
-
dall’altro, possono diventare strumenti utili di ricerca, capaci di rivelare la presenza di sostanze tossiche con maggiore rapidità rispetto agli organismi viventi.
Proprio da questa intuizione è nato un esperimento pionieristico per il Mediterraneo: il progetto CHEMPEL, che studia se le microplastiche possano davvero diventare nuovi traccianti dell’inquinamento marino.
Microplastiche come traccianti di inquinamento
Sfruttando la capacità delle microplastiche di assorbire gli inquinanti, l’INGV – insieme al CNR-ISMAR, CNR-ICCOM, al Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – ha avviato per la prima volta nel Mediterraneo un esperimento innovativo: CHEMPEL (CHEMistry of the PELlets).
Il progetto, parzialmente finanziato dal Ministero della Salute, fa parte del programma “La chimica e la genomica: una strategia sinergica per l’individuazione dei contaminanti associati alle microplastiche negli alimenti”.
L’obiettivo è confrontare l’assorbimento di inquinanti organici persistenti (IPA e PCB) da parte dei mitili e dei pellets per capire se le microplastiche possano essere traccianti più efficaci e rapidi rispetto agli organismi viventi.

Perché usare i pellets
L’utilizzo delle microplastiche presenta diversi vantaggi:
-
possono essere impiegate in qualunque condizione ambientale,
-
sono facili e veloci da trattare e analizzare,
-
consentono un monitoraggio più standardizzato rispetto ai mitili.
Se confermato, questo approccio permetterebbe di sostituire i bioindicatori tradizionali con materiali sintetici, riducendo i costi e aumentando la rapidità delle analisi.
Dove si è svolto l’esperimento
L’esperimento è iniziato nel maggio 2019 nel Golfo della Spezia, scelto per la presenza di zone costiere con diversi livelli di attività antropica.
Tre i siti di monitoraggio:
-
il pontile galleggiante della Piscicoltura Portovenere (alle Grazie),
-
il pontile fisso della Scaforimessa Majoli (Marina del Canaletto),
-
la banchina in cemento della Cooperativa dei Mitilicoltori Spezzini (Santa Teresa), fuori dalle aree di allevamento.
In ogni sito i ricercatori hanno posizionato una resta di mitili accanto a tre gabbie in acciaio progettate per contenere due tipi di pellets – polietilene e polipropilene – separati da un disco di legno.
Le gabbie sono state collocate in tre diverse posizioni:
-
una emersa,
-
una galleggiante,
-
una immersa.

Come si è svolto il monitoraggio
Durante il primo mese, da ogni gabbia sono stati prelevati circa 25 pellets a settimana per valutare le prime fasi di assorbimento dei contaminanti.
Successivamente, i prelievi sono diventati mensili.
Parallelamente, i ricercatori hanno raccolto campioni di acqua e di mitili per confrontare le concentrazioni di inquinanti nei due sistemi.
Le analisi di laboratorio hanno incluso:
-
determinazione chimica di IPA e PCB assorbiti,
-
analisi spettroscopiche (ATR) e fisiche (porosità e colorazione superficiale),
-
misurazioni ambientali con una sonda multiparametrica (temperatura, salinità, torbidità, pH),
-
registrazione continua di piovosità e irraggiamento, parametri che influenzano i processi di assorbimento/desorbimento.


I risultati
L’esperimento si è concluso nel giugno 2020 con risultati molto interessanti.
I risultati dei primi mesi di esperimento evidenziano che le microplastiche di polietilene galleggianti assorbono maggiori quantità di inquinanti rispetto alle altre categorie studiate (equivalenti immersi e anche delle microplastiche di polipropilene, sia galleggianti che immersi). Questo fatto non era ancora stato dimostrato da esperimenti condotti in precedenza, perché non era stato fatto un confronto fra pellets galleggianti e pellets immersi. La spiegazione di questo risultato è legata al fatto che lo strato marino superficiale è quello più “ricco” di sostanze idrofobiche (che non si sciolgono in acqua), meno dense dell’acqua (come il petrolio) e che quindi si concentrano nello strato superficiale come dimostrato da studi precedenti.
Lo studio, inoltre, ha evidenziato che i pellets sono dei traccianti più rapidi di eventuali aumenti di inquinamento dell’acqua rispetto ai mitili. Se posti in appositi contenitori e fissati in modo che non siano trasportati via dalle correnti, possono quindi sostituire i mitili come indicatori di sostanze tossiche. Diventano così rilevatori veloci (e di elevata sensibilità) di inquinamento, utili a individuare tempestivamente situazioni critiche.
Dati e prospettive
È importante sottolineare che comunque i livelli di inquinanti rilevati nei mitili non superano i limiti di legge. I dati preliminari del progetto sono stati presentati a La Spezia durante il convegno SIRAM 2019 (Società Italiana di Ricerca Applicata alla Molluschicoltura) e hanno costituito la base di tre tesi di laurea presso l’Università di Pisa.
I risultati aprono la strada a nuovi protocolli di monitoraggio, più agili e sostenibili, in cui le microplastiche – paradossalmente – da inquinanti diventano strumenti di conoscenza e tutela ambientale.
Immagine di copertina: resin pellets raccolti su una spiaggia dell’Isola di Pianosa (foto di Erika Mioni).
Le immagini sono di M. Locritani, INGV – SP